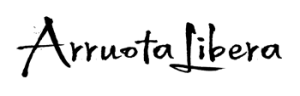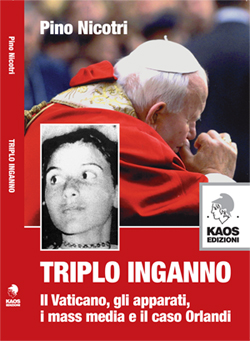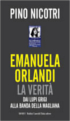Il superamento della religione nell’Anti-Dühring di Engels
L’ateismo del comunismo primitivo
È impossibile dar torto a Engels quando considera ridicola l’idea di Dühring di “abolire” la religione nella società socialista. Infatti il socialismo scientifico ha sempre detto ch’essa è soltanto un epifenomeno, una sovrastruttura che si estinguerà da sé, insieme allo Stato politico, quando il socialismo sarà realizzato.
Ciò che non piace, nella sintesi engelsiana sulla posizione del socialismo in merito al fenomeno religioso, è un’altra cosa. Scrive nel suo Anti-Dühring: “Agli inizi della storia sono anzitutto le potenze della natura quelle che subiscono questo riflesso…”, assumendo col tempo “svariate e variopinte personificazioni”. Quale riflesso? “Ogni religione non è altro che il fantastico riflesso nella testa degli uomini di quelle potenze esterne che dominano la sua esistenza quotidiana, riflesso nel quale le potenze terrene assumono la forma di potenze ultraterrene”.
Molto feuerbachiana questa definizione della religione. Cerchiamo di capir bene cosa Engels voleva dire. Anzitutto non si sta riferendo alle religioni politeistiche, tipiche dello schiavismo, poiché subito dopo parla di “mitologia comparata” dei popoli indoeuropei, di cui i Veda induistici costituiscono l’origine ancestrale. Egli si sta riferendo alle religioni più primitive, quelle clanico-tribali, cioè quelle passate alla storia col nome di “totemico-animistiche”.
Queste però non erano religioni che riflettevano rapporti sociali di tipo antagonistico. Erano dunque così alienanti? così predisposte a fuorviare gli uomini dall’idea di doversi liberare da rapporti sociali frustrati? Assolutamente no, anche perché appunto non esisteva ancora lo schiavismo.
Ma facciamo ora mente locale e cerchiamo di ricordare come sono fatte le tante pitture rupestri dell’uomo preistorico trovate in vari luoghi del pianeta. Presentano forse una simbologia magico-religiosa o animistico-totemica? Purtroppo per Engels dobbiamo dire che appaiono molto realistiche e naturalistiche, per quanto le figure siano stilizzate, appena abbozzate. Esse dovevano soltanto rimandare ad altro, non avevano la pretesa d’aver un significato in sé. Il pittore preistorico non voleva rappresentare tutto se stesso, né faceva della sua arte una forma di consolazione o di evasione o di protesta in rapporto alle contraddizioni della sua vita. Picasso rimase molto stupito di questo realismo ingenuo e cercò d’imitarlo nelle sue raffigurazioni dei tori.
Ora, perché questa assenza di riferimenti religiosi? Il motivo è molto semplice: nel comunismo primitivo non esisteva alcuna religione. Il fatto che seppellissero i loro morti con tutto ciò che d’importante avevano usato in vita, non voleva affatto dire che basassero la loro esistenza in funzione di una credenza religiosa. Non c’erano sacerdoti che si distinguevano dal resto della comunità, rivendicando un potere particolare. Se c’erano sciamani o stregoni, non svolgevano riti non compatibili con le funzioni attribuite alla natura. Alcuni eminenti studiosi han detto che non c’era la religione perché il cervello degli uomini primitivi non era sufficientemente sviluppato. Allora non lo è neppure quello dei socialisti! Ancora oggi ci si imbatte in qualche studioso di mentalità borghese che legge il passato con gli occhi del presente o che ritiene sia impossibile non credere in un’entità superiore.
Gli uomini primitivi erano forse religiosi perché mancava la scienza? Ma la fede cieca nella scienza non rende forse altrettanto superstiziosi? L’unica vera scienza è forse quella occidentale? La conoscenza diretta della natura, trasmessa per prove ed errori attraverso le generazioni, va considerata non scientifica? La scienza è davvero “scientifica” solo quando fa esperimenti in laboratori asettici, neutrali, non influenzati dall’ambiente esterno? La vera scienza è soltanto quella che sa “dominare” la natura perché ne conosce a fondo tutte le sue leggi?
Sono tutte domande le cui risposte, oggi, dovrebbero essere scontate, anche perché l’uomo primitivo, avendo una visione olistica delle cose, era inevitabilmente molto più scientifico degli odierni scienziati, sempre molto settoriali e privi di senso etico, in quanto, se sono idealisti, non si ritengono responsabili quando le loro ricerche vengono usate dalla politica o dall’economia in maniera negativa, oppure, se sono venali, si chiedono come ricavare dalle loro ricerche un utile economico. Quando parliamo di medicina non stiamo forse lì a chiederci perché in occidente si curi soltanto l’organo malato e non si abbia un vero rapporto col paziente?
Vivendo rapporti sociali naturali, l’uomo primitivo non poteva avere alcuna religione, e se aveva delle credenze che oggi qualifichiamo, sbagliando, col termine di “religiose”, esse non lo facevano sentire in balìa delle forze della natura, non provenivano da un senso d’impotenza nei confronti di tali forze, poiché la natura era considerata “madre”, non “matrigna”. Semmai è sotto lo schiavismo che si inizia ad attribuire a forze innaturali o sovrannaturali la causa e, insieme, il rimedio delle proprie frustrazioni. È così che si creano delle personificazioni simboliche, astratte, di ciò che si vive (il male) e che si vorrebbe vivere (il bene) nella realtà.
Gli uomini primitivi non si sentivano “dominati” dalla natura, né avvertivano il desiderio di “dominarla”. Per loro la natura era una partner dotata di personalità autonoma (che, p.es., non si poteva ferire con l’uso dell’aratro, per non devastarne il ventre, come dicevano tante popolazioni antiche). Era considerata una madre severa, esigente, ma anche protettiva, rassicurante, con cui misurarsi alla pari, man mano che si diventava adulti, senza mai scordarsi che gli esseri umani sono tutti “figli della natura”. Concepivano la natura come fonte esclusiva1 delle loro risorse, della loro stessa vita. Se per il fatto di ritenerla una sorta di “divinità” è necessario definirli “religiosi”, indubbiamente lo erano. Ma allora dovremmo considerare tali anche gli antichi filosofi ilozoisti o panpsichisti, quando invece erano fondamentalmente atei.
Credere che esista un aldilà o che la morte sia una forma di passaggio da un’esistenza a un’altra non significa essere “religiosi”, poiché anche la scienza parla di eternità e infinità della materia e dell’universo che la contiene, e della sua perenne trasformazione. Per non essere “religiosi” è sufficiente non credere in un dio onnipotente, onnisciente, onnipresente, preveggente…, in grado di leggere il pensiero umano, di anticiparne le decisioni, di condizionarne le scelte, di indurlo in tentazione e altre amenità del genere, che fanno sentire l’uomo una marionetta nelle mani di dio. Chi crede nell’eternità della natura, non ha bisogno di credere in dio, oppure crederà in un dio che sostanzialmente avrà caratteristiche umane. Il livello massimo di religione che potevano avere gli uomini preistorici era il culto degli antenati, che è quanto di più umano vi possa essere.
Il secondo aspetto sbagliato nella sintesi di Engels, sullo sviluppo del fenomeno religioso, è che non mette in relazione il paganesimo con lo schiavismo. Eppure avrebbe dovuto essere scontato. Tutte le religione cosiddette “pagane” o politeistiche sono nate quando già esisteva la fine del comunismo primitivo. Tali religioni avvertivano la natura come un pericolo o una minaccia, in quanto gli uomini vivevano così i loro rapporti sociali. Cioè consideravano la natura uno strumento nelle mani degli dèi, che lo usavano a loro discrezione, il più delle volte per punire gli uomini di qualche mancanza; oppure veniva invocato l’aiuto degli dèi per nuocere al nemico.
Non è mai esistito – come invece dice Engels – un periodo in cui gli uomini temevano le forze della natura, antecedente a un secondo periodo in cui hanno iniziato a temere le forze sociali antagonistiche. Dopo la fine del comunismo primitivo l’uomo ha subito avvertito il proprio simile come un nemico, e là dove non riusciva a sconfiggerlo, a sottometterlo, s’inventava delle forze supplementari astratte che potessero aiutarlo. Oppure chi era in grado d’imporsi con la forza o l’astuzia, escogitava delle entità simboliche per giustificare la propria superiorità.
Che poi sotto il paganesimo ci fossero tante divinità, mentre sotto le cosiddette “religioni del libro” ve ne fosse una sola, non ha molta importanza. Forse le religioni monoteistiche sono emerse quando il peso dei condizionamenti sociali antagonistici era troppo forte per essere sopportato. Esse infatti appaiono come una forma d’illusione a un livello superiore, più astratto e sofisticato: hanno sostituito qualcosa che aveva fatto il suo tempo, nella convinzione che occorressero ideali più elevati, da realizzarsi a tutti i costi. Le religioni monoteistiche sono legate più alla storia che non alla natura, più all’azione che non alla contemplazione, più a una organizzazione collettivistica con addentellati politici che non a un approccio alla divinità di tipo clanico-parentale o individuale, più a una sensibilità universale che non a un riferimento urbano o locale, più a rigidi dogmi che non a riti conformi ai ritmi della natura. Il passaggio da tante divinità che si possono rappresentare visivamente a un unico dio non rappresentabile o, come nel cristianesimo, a un personaggio che insieme è umano e divino, potrebbe anche essere visto come una forma di cripto-ateismo, di disincantamento da una certa ingenuità di fondo.
Insomma la formazione e lo sviluppo delle religioni sono stati molto sfaccettati nei secoli e nei diversi luoghi geografici, per cui non è possibile stabilire un “prima” e un “dopo” tra una forma e l’altra. L’unica cosa che si può dire è che, se si escludono le religioni animistico-totemiche, tutte le altre riflettono rapporti sociali conflittuali, cui s’è cercato di trovare una spiegazione fantastica a seconda delle circostanze. Tutti gli dèi servono per giustificare la posizione delle classi dominanti, o possono essere inventati per contrastare tale posizione. Le divinità possono assumere col tempo nomi, funzioni, caratteristiche, modalità d’azione… incredibilmente diversi, a seconda della fantasia umana: quello che non cambia è che esse vengono sempre usate in rapporto agli antagonismi sociali.
Anche oggi esistono divinità laicizzate che chiamiamo Stato politico, Libero mercato, Scienza laboratoriale, Diritti umani universali, Democrazia parlamentare… Persino la Scrittura, rispetto alla semplice Oralità, è considerata una divinità. Siamo in grado di “deificare” qualunque cosa, vivendo in sua funzione, sottomettendoci come servi: il denaro da accumulare, lo shopping per spendere il denaro accumulato, il sesso da godere, la droga per evadere, lo sport della squadra del cuore, l’attività ginnica che tiene sempre in forma, la medicina che risolve ogni problema fisico, l’alimentazione che rende sani, giovani e belli, i film che fanno sognare, la musica che distrae, le chat che coinvolgono, il gioco d’azzardo che ipnotizza, l’analista cui confidare i nostri problemi… Quando dominano i rapporti antagonistici, tutto può essere trasformato in una “religione”, persino l’ideologia con cui vengono criticati questi rapporti.
La religione è una fissazione da cui è molto difficile liberarsi, se non ci si libera di ciò che la origina. Con uno sforzo di volontà personale al massimo si può passare da una fissazione a un’altra. Tutto può diventare una forma di dipendenza, esattamente come le classiche religioni. L’oppio dei popoli oggi è il capitalismo, ma, in alcuni Paesi del mondo, per 70 anni è stato il cosiddetto “socialismo reale”. Gli stessi Marx ed Engels avevano il culto per la scienza e la tecnica e avevano concepito una transizione socialista che non prescindesse minimamente da ciò che la borghesia aveva realizzato sul piano tecnologico.
Ecco perché oggi, se davvero vogliamo realizzare un socialismo democratico, dobbiamo rimettere tutto in discussione. Oggi ci vantiamo di conoscere la natura molto meglio di quanto potessero fare gli uomini prima della rivoluzione tecnico-scientifica del Settecento. Ma chiediamoci: forse per questo abbiamo eliminato il concetto di “religione”? O non l’abbiamo piuttosto trasformato in qualcosa di più laico, conseguente al fatto che la società borghese ha aumentato, col consumismo, gli oggetti di cui possiamo disporre per illuderci di superare le nostre alienazioni?
Tutte queste opinioni limitate di Engels non dipendono solo dal fatto che risalgono a 150 anni fa, ma anche e soprattutto da una visione piuttosto terribile della preistoria. Scrive a tale proposito: “Gli uomini, appena nelle origini emergono dal mondo animale (in senso stretto), fanno il loro ingresso nella storia: ancora mezzo animali, rozzi, ancora impotenti di fronte alle forze della natura, ancora ignari delle proprie; perciò poveri come gli animali e di poco più produttivi di essi”. In queste condizioni verrebbe da chiedersi come sia stata possibile un qualunque forma di progresso.
Se osserviamo che talune comunità primitive, ancora oggi esistenti, sono rimaste ferme al neolitico, pur essendo consapevoli, almeno a grandi linee, di un certo progresso tecnico-scientifico e urbanistico, avvenuto non molto lontano dai loro villaggi, verrebbe quasi da pensare che i membri di tali comunità non appartengano affatto alla specie “homo sapiens”. A Engels sarebbe parso del tutto incredibile che, pur consapevoli di un certo progresso tecnologico al di fuori del loro habitat, tali comunità abbiano preferito rinunciarvi altrettanto consapevolmente, nella convinzione che, così facendo, avrebbero potuto conservare meglio le caratteristiche della loro identità, le proprietà del loro ambiente vitale.
Purtroppo gli stessi etnologi che visitano tali comunità spesso non sono in grado di capire ch’esse, a causa dei condizionamenti esterni che subiscono, non sono più come vorrebbero essere. Esse sanno benissimo che il cosiddetto “mondo civilizzato” non vede l’ora di espropriarle delle loro risorse naturali. Il fatto stesso che vi siano degli studiosi che vanno a conoscerle come se fossero animali in via di estinzione, è indicativo del profondo abisso che ci separa da loro. Per Engels il criterio fondamentale che spiega la differenza tra “loro” e “noi” è il rapporto con la natura, che per loro sarebbe di “dipendenza”, mentre per noi è di “dominio”, come se il concetto di “dominio” ci caratterizzasse, nei confronti della natura, come “esseri umani”.
Dunque a che serve il sedicente “socialismo scientifico” se nei confronti della natura ha lo stesso atteggiamento “imperialistico” del liberismo borghese? Abbiamo davvero bisogno di “razionalizzare” un atteggiamento che è sbagliato nei suoi presupposti di fondo? Finché per noi il rapporto con la natura si configura solo come dominio, che possibilità abbiamo di diventare noi stessi, cioè “enti di natura”? È forse giusto ritenere che nel mondo primitivo l’uguaglianza fosse soltanto un prodotto inevitabile della loro impotenza nei confronti della natura? un effetto della loro povertà materiale? della loro incapacità produttiva? Per quale motivo è così difficile capire che una qualunque produzione umana deve essere compatibile con le esigenze riproduttive della natura?
Là dove c’è paganesimo, c’è sempre schiavismo. E lo schiavismo è sempre basato sui rapporti di forza, in cui p.es., sul piano personale/sessuale, l’uomo domina la donna. Se esistono riferimenti ancestrali al primato della natura, all’eternità-infinità dell’universo ecc., ciò va considerato un retaggio del comunismo primitivo, che ha caratterizzato la vita del genere umano in tutto il pianeta per almeno un milione di anni (in genere si fa partire lo schiavismo a circa 6000 anni fa).
Là dove c’è schiavismo, non è possibile considerare il paganesimo migliore del cristianesimo: semmai si possono fare differenze tra ortodossia religiosa (di derivazione greco-bizantina) e cattolicesimo-romano, in cui il papato si considerava politicamente superiore agli imperatori.
Il cristianesimo è quella religione che favorisce il passaggio dallo schiavismo al servaggio, in quanto ha un maggior senso dell’etica, proveniente dall’ebraismo. Questo almeno fino a quando, assumendo atteggiamenti neopagani, desunti dalla passata civiltà greco-romana, il cristianesimo non arriverà a trasformare la dipendenza personale del servaggio in dipendenza contrattuale del lavoro salariato. Un processo, quest’ultimo, iniziato in Italia, con la formazione dei Comuni borghesi e sviluppatosi enormemente con la Riforma protestante, specie nella variante calvinistica. Criticando il cattolicesimo borghese del papato, la Riforma sembrava voler riprendere la severità del cristianesimo primitivo; invece estese soltanto la corruzione a tutta la società civile, facendo di ogni credente il pontefice di se stesso.
Tutte queste cose: schiavismo/paganesimo, servaggio/ortodossia-cattolicesimo, capitalismo/protestantesimo vanno superate con una forma di socialismo democratico e ateistico (umano-naturalistico), che riprenda lo stile di vita del comunismo primitivo, l’unico in cui vigeva l’uguaglianza sociale e quindi quella di genere. Questo per dire che non potremo ereditare nulla di significativo né dallo schiavismo pagano, né dal servaggio cristiano, né dal capitalismo borghese, e neppure dal socialismo statale (di matrice russa) o mercantilistico (di matrice cinese).
Nota
1 Oggi non usiamo più il termine “esclusiva” ma “prioritaria”, in quanto ci vantiamo di poter costruire artificialmente ciò di cui abbiamo bisogno.
www.socialismo.info